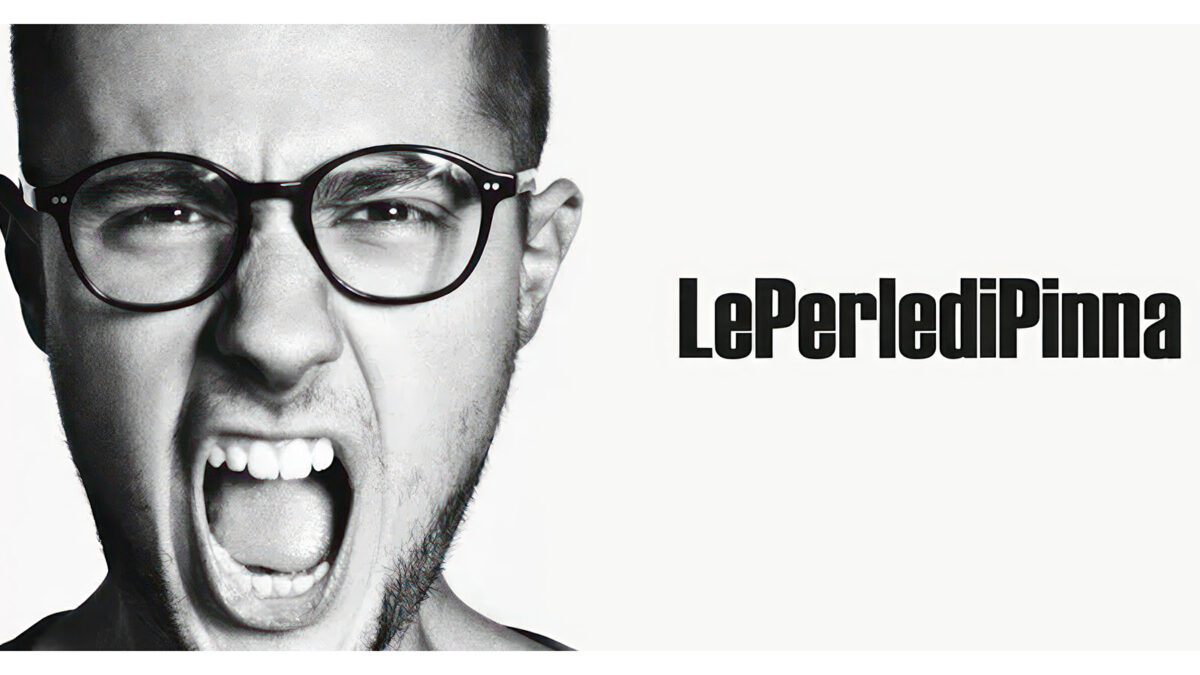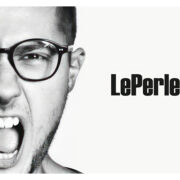Davide Fiore è un regista nato e cresciuto a Torino dove si è diplomato allo IED (Istituto Europeo di Design, Moda e Arti Visive) ed è poi diventato “cittadino del mondo”. Viaggia due volte al mese, prevalentemente per lavoro, ha conosciuto molte città metropolitane, immense e globali, ma quella che gli ha toccato l’anima è New York, dove ama tornare frequentemente. Ed è qui che nasce un’idea: raccontare la città in modo inedito. Compiendo un lavoro di scavo nei fotogrammi di quelle pellicole tanto amate ed entrate a far parte della storia del “divismo” hollywoodiano, è riuscito a cogliervi uno spirito diverso.
Seguendo un fil rouge che attraversa i classici , come Colazione da Tiffany, Quei bravi ragazzi, Il Padrino, ed indirizzandosi verso i blockbusters più recenti come Serendipity, Il Diavolo veste Prada o Vanilla Sky, Davide ha voluto ricostruire un percorso filologico volto ad entrare nei miti del “sogno americano” e a svelarne gli archetipi per capire cosa si nasconde dietro le immagini-simbolo più arcane. Si può così scoprire quanto la leggendarietà di alcune strade o location situate nel cuore della Grande Mela siano, talvolta, il frutto di una ricostruzione aurea e patinata, che è entrata nell’immaginario collettivo e a cui non sempre corrisponde un riscontro nella realtà. Ciononostante New York continua ad essere un crocevia per le ambizioni e la fame di gloria delle nuove generazioni; ma anche il luogo dove, con le proprie energie e il proprio talento, è possibile realizzare i propri progetti. Alpi Fashion Magazine ne ha parlato con il regista che il 25 marzo, a partire dalle ore 19 presenterà alla ZAD – Zona Arte Detour di Roma la mostra “I’ve already seen it somwwhere” dedicata ai luoghi cult della città.
Come nasce l’idea di realizzare una mostra a New York attraverso i fotogrammi dei classici cinematografici?
È nata 4 anni fa quando per lavoro e non come turista mi sono trasferito a New York, trovandomi da solo in una situazione completamente nuova. In realtà, appena ho messo piede in questa città, mi sono reso conto che è come se la conoscessi già attraverso le pellicole dei grandi classici americani del passato e attraverso le serie tv del presente. Pur non essendoci mai stato, ne avevo familiarità. L’ho voluta così scoprire in una chiave diversa dai cinque monumenti e quattro quartieri canonici che rimangono impressi nell’immaginario comune. Dopo alcuni mesi dal mio primo arrivo sono tornato e, fermando i fotogrammi dei film, come Il Diavolo Veste Prada, attraverso un lavoro di ricerca incrociata tra i numeri civici e i corrispondenti numeri di telefono nelle rubriche, sono riuscito a rintracciare l’esatta via dove si sono svolte determinate scene cult. Da allora, una volta l’anno prendo l’aereo e vado per un mesetto nella Grande Mela. L’ultima volta ho visitato anche il quartiere dove viene girata la serie Law and Order. Mi sono reso conto che il cinema ha reso speciali ed iconografici luoghi che di per sé sono molto banali.
Perché ha scelto questo titolo “I’ve already seen it somewhere”?
Il titolo suggerisce che quello che ho visto a New York non succede da altre parti. Nella mia vita ho viaggiato e tuttora viaggio tantissimo, almeno due volte al mese, ma il taxi giallo l’ho visto solo a Manhattan. Se vai a Brooklyn i taxi sono neri. L’hot dog a 1 dollaro per strada lo trovi solo a New York.
Quali sono gli stereotipi che andrebbero sfatati?
Uno stereotipo infranto è che sia una grande città. In realtà, se si viaggia, ci si rende conto che è come molte altre città del mondo, Los Angeles, Dubai, Shanghai. Anzi, ce ne sono anche di più grandi. E poi c’è lo stereotipo degli Skyline, i grattacieli freddi e glaciali. In realtà, non è così. Lo Skyline di Manhattan, visto da Brooklyn, dal vivo ha il suo fascino e lascia senza fiato. New York è una città nostalgica/malinconica.
Perché dice che è malinconica?
Beh, entrare in una metropolitana, che è una delle più antiche d’America, desta un po’ di malinconia. E poi è una città piovosa; solo a New York esce il fumo dai tombini, un fenomeno che da poco ho scoperto sia dovuto ai tubi di riscaldamento molto alti. E’ una città per solitari. Non è a portata di famiglia.
Ombelico del mondo, incrocio di antiche e nuove migrazioni. Ieri con la valigia di cartone, oggi con il trolley ci si trasferisce per trovare migliore fortuna…..
Assolutamente sì. La migrazione oggi è totalmente cambiata. Tenga conto che New York è stata per anni il porto più comodo per entrare negli Stati Uniti. Il mio bisnonno si era trasferito lì negli anni Trenta. A proposito, di recente, mi sono recato ad Ellis Island, che è l’isola dove approdavano i migranti. Di fronte c’è la Statua della Libertà e un archivio con tutte le firme dei migranti. Ho cercato la firma del mio bisnonno e l’ho trovata.
Quali sono gli aspetti che più ti hanno più colpito, girovagando nei quartieri della Grande Mela?
Il primo aspetto che mi ha colpito è la lotta. C’è una competizione molto serrata. Il secondo aspetto è la multietnicità. La prima domanda che ti fanno è “da dove vieni”. Ho scoperto che è ereditata dal 1600.
Una città dove le etnie convivono bene insieme. Non crede che anche questo sia un luogo comune da sfatare?
Se si riferisce ai conflitti razziali tra neri e bianchi e agli scontri con la Polizia, New York è cambiata tantissimo negli ultimi vent’anni. È una città multietnica, anzi un melting pot, una combinazione tra diverse etnie. Anche i quartieri più degradati, facile approdo per la criminalità di strada, sono stati rimessi a posto. A Los Angeles invece la tensione è ancora molto alta. Personalmente, nonostante ogni tanto si senta qualche sparo, a New York non mi sono mai sentito a rischio. Certo, ci sono dei quartieri che è meglio evitare, come in ogni altra città del mondo.
L’arrivo di Trump ha generato scontri tra fasce di popolazioni avverse. Anziché unire le sue decisioni sembrano dividere. L’iniziativa di frenare l’immigrazione costruendo muri e barriere, come quelle con il Messico, ha fatto molto discutere. Da regista e fotografo, qual è la sua sensibilità in merito a questi temi di attualità?
New York, si sa, non ha votato Trump perché non ne condivide le proposte. Non mi interesso molto di politica, ma credo che l’avversione nei suoi confronti sia stata enfatizzata. Ha delle idee poco condivisibili, ma per fortuna ci sono gli altri organi di Governo che finora lo hanno sempre bloccato. Del resto, quella di ostacolare l’immigrazione era stata anche la politica degli inizi del primo mandato di Obama. Chiaramente, sono contrario ad ogni forma di chiusura e a governi totalitari. Anche in Europa, la situazione si sta capovolgendo. La Germania, che è stata sempre un modello di “città aperta”, sta rivedendo le proprie politiche di accoglienza.
Cambiamo argomento e torniamo all’arte. Com’è nata la sua passione per il cinema americano?
È arrivata un po’ tardi. In realtà, sono nato come regista di videoclip musicali, ma la passione per il cinema, ce l’avevo fin da piccolo. Per ragioni di sopravvivenza ho dovuto canalizzarla in occupazioni meno creative. Così ho iniziato a lavorare come videomaker e a realizzare corporate video per grandi aziende. Quando sono arrivato a New York ho capito che il cinema non è un obiettivo irraggiungibile. Qui è normale trovare film-makers che, cercando opportunità, contemporaneamente, producono. La burocrazia è molto veloce e le istituzioni ti appoggiano e ne traggono beneficio. Pensi che il Comune di New York guadagna solo di tasse 400 milioni di dollari dalle produzioni cinematografiche.
New York è una città molto ricca di impulsi artistici. Non crede che vi sia lo stereotipo del “sogno americano”? Accade che chi arriva in questa terra in cerca di fortuna trova una realtà diversa da quella per anni attesa?
Assolutamente sì. New York è una città che lascia molta libertà agli artisti, sia in termini di espressione che di contatti. Offre tante opportunità per i galleristi e i cineasti. Certo, ha i suoi pro e i suoi contro. Se si vola in alto bisogna avere il talento che ne compensa le ambizioni. Se si parte dall’idea di trovare una città “simil-italiana” non si va avanti. Qui si fanno i lavori più umili per pagare gli studi e finanziare i propri progetti. Arrivare a New York di per sé non è una garanzia, ma se ci si impegna sodo il proprio lavoro viene riconosciuto. Conosco ragazzi italiani che producono un cortometraggio all’anno. L’Italia tarpa le ali, qui invece non conta la raccomandazione, bensì il merito.
Quali sono i suoi progetti nell’immediato futuro?
Ho appena finito di lavorare a due fashion movie e ad un serie TV girata a Londra e montata tra Torino e Milano. A fine mese mi trasferirò in California dove lavorerò come montatore.
Tornerà mai a vivere in Italia?
Ci ho provato per 8 anni. Ho chiuso la partita Iva a dicembre. Ho un amore viscerale per questo paese, ma lavorare nel campo cinematografico è difficile. Bisognerebbe scendere a compromessi che non ho intenzione di accettare.
Quali?
Dover lavorare a basso costo, solo per la “visibilità” e senza prospettive. Oppure essere fidanzati/sposati con una determinata persona. Ho vissuto per anni a Torino e la domanda ricorrente è “chi ti manda?”. Non si tiene conto del curriculum.
Marianna Gianna Ferrenti